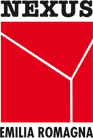Era il 17 dicembre 2010, quando Mohamed Bouazizi si diede fuoco nelle strade di Sidi Bouzid. Nei mesi a seguire, la Tunisia e l’intera regione andarono in fiamme, la gente cominciò a scendere in piazza, chiedendo democrazia e giustizia sociale. Due dittatori caddero: Zine el-Abidine Ben Ali in Tunisia e Hosni Mubarak in Egitto. L’Unione europea fu velocissima nell’annunciare il suo sostegno “a quel processo di mutazione profonda” in corso, impegnandosi ad “ascoltare le richieste fatte dalla società civile”.
Era nato così quel moto d’indipendenza che i media non tardarono a chiamare “la primavera araba”, un vento di speranza per la democrazia e la giustizia sociale in tutto il Mediterraneo. Un processo contraddetto però solo un anno dopo, con la decisione dei ministri europei di avviare negoziati con la Tunisia, l’Egitto, il Marocco e la Giordania (Deep and comprehensive free trade agreement- Dcfta), per approfondire e completare le misure di liberalizzazione del commercio già avviate nel 1995, complici quei regimi dittatoriali che la primavera pensava di aver confinato nel passato.
Siamo tornati a Tunisi nei giorni scorsi, per il Forum sociale mondiale, il primo nei paesi arabi, tra le edizioni più significative dell’evento, proprio perché approdato in terra di profondi mutamenti. Lo scontento per una rivoluzione incompiuta, soprattutto in ambito economico, e la rabbia per la responsabilità determinante dell’Europa nella neutralizzazione della sua forza di cambiamento in questo ambito sono evidenti.
“Abbiamo abbattuto la dittatura, ma non siamo ancora riusciti nemmeno a scalfire il modello di sviluppo della dittatura”, ci spiega un docente e sindacalista tunisino, già dirigente nel settore scuola superiore e università, che preferisce mantenere l’anonimato. Nei giorni del Forum, tutto intorno a noi ci ha parlato di questo tema.
L’idea d’integrare progressivamente la sponda Sud nel mercato comune nasce a metà degli anni novanta, quando l’Europa lancia il Processo di Barcellona con l’obiettivo di stabilire un’area di libero scambio nel Mediterraneo, facendo approvare degli accordi di associazione bilaterali (bilateral association agreements). Gli accordi sono stati firmati con tutti gli Stati della regione tra il 1995 e il 2002 e sono entrati in vigore tra il 1998 e il 2006. Il tutto mentre ulteriori liberalizzazioni tentate nel mercato agricolo, nei servizi, negli investimenti, nella proprietà intellettuale e nelle forniture pubbliche venivano stoppate nel piano multilaterale con la Doha development agenda, arenata presso l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc/Wto), per i numerosi e crescenti dubbi che i paesi emergenti e quelli meno sviluppati nutrivano rispetto alla sua reale efficacia in termini di occupazione e di benessere diffuso.
Nessuno ha saputo riassumere lo scopo della politica commerciale europea meglio del Commissario al commercio Ue Karel De Gucht. Durante un’intervista radiofonica nel luglio 2012, De Gucht ha descritto il suo ruolo come segue: “Quello che cerco di fare è trovare nuovi mercati per i nostri prodotti, è per questo che ci apprestiamo a negoziare una serie di accordi bilaterali”.
La Commissione europea giustifica questo suo scegliere il commercio prima dei diritti con un dato: il 90 per cento della crescita mondiale nei prossimi 10-15 anni si verificherà fuori dall’Europa, ed è per questo che i nostri prodotti dovranno trovare lavoratori a buon mercato e nuovi acquirenti, costi quel che costi. Il mantra della Commissione insiste su “Commercio, crescita, occupazione”, e sostiene che “in media, ogni miliardo di euro di esportazioni in più crea 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in Europa”, senza meglio precisarne la qualità, né tantomeno la quantità di occupazione distrutta e/o sottoposta alla pressione della concorrenza internazionale mediante l’abbattimento delle barriere doganali, dentro e fuori l’Europa.
Quello che è successo nei paesi della sponda Sud del Mediterraneo, già con le prime aperture seguite ai vecchi negoziati, ce lo racconta, numeri alla mano, lo stesso rappresentante sindacale: “Il nostro paese ha cominciato a metà degli anni novanta a firmare i primi accordi di liberalizzazione commerciale con l’Europa, perché erano sostenuti da un rapporto della Banca mondiale in cui si diceva che la Tunisia avrebbe guadagnato un 3 per cento di Pil, oltre ad attirare investimenti esteri.
Al tempo, l’associazione nazionale degli imprenditori protestò per non essere stata consultata e previde che un terzo del tessuto economico, parliamo di 120.000 imprese, sarebbe stato danneggiato”. Le finanze pubbliche di Tunisi dipendevano per il 30 per cento dalle tariffe sulle importazioni: il loro abbattimento ha aggravato deficit e debito estero: “Oggi – continua il nostro interlocutore – il 30 per cento del bilancio dello Stato è finanziato attraverso il debito estero. Abbiamo subito un drastico taglio dei trasferimenti sociali, mai ripristinati dopo la caduta del regime: è stata la fine per il sostegno ai prezzi al consumo, la spesa per l’educazione, la sanità pubblica, i bilanci delle autorità locali”.
Il prezzo di tutto questo la gente lo paga con la disoccupazione: nonostante il dato sia secretato, si stima che ci sia oggi un 18-20 per cento di disoccupazione in Tunisia, che arriva al 25 per cento per le donne e al 35 per i diplomati e/o laureati. Più colpite sono le regioni agricole dell’interno, perché le prime liberalizzazioni hanno toccato i prodotti di quel settore; le eccedenze del mercato italiano, spagnolo e greco hanno potuto essere scaricate qui, con il risultato che nelle aree rurali la disoccupazione oscilla tra il 30 e – come nel caso della regione di Tataouine – il 51 per cento.
Il rischio di una sovranità economica ancor più limitata per i paesi del Sud del Mediterraneo, con l’entrata in vigore dei nuovi accordi, è tangibile, considerato che i testi degli accordi non sono noti e la loro pubblicazione non è obbligatoria, perché classificati dalla Commissione come “segreto commerciale”. Il Parlamento europeo, dopo la riforma del Trattato di Lisbona, è chiamato tuttavia a discuterne, emendarne e votarne la versione finale, mentre i Parlamenti dei paesi membri sono chiamati a ratificarli. In questo spazio è possibile agire, a livello europeo e nazionale, anche se la recente approvazione da parte del Parlamento europeo a larga maggioranza del Fta, il trattato di libero scambio con Colombia e Perù, dimostra che non c’è da star tranquilli. Preoccupa, infatti, la “discrezione” con la quale vengono condotti i negoziati e la prevalenza degli interessi economici e commerciali interni rispetto a considerazioni di principio e di equità realmente condivise con i paesi della sponda Sud.
“Si vuole esportare un modello di sviluppo che ci ha portato alla crisi”, sostiene Leopoldo Tartaglia, coordinatore del dipartimento Politiche globali della Cgil, che a Tunisi, in collaborazione con le reti sindacali locali, ha lanciato il nuovo Osservatorio sul commercio internazionale “Trade game/il commercio non è un gioco”, creato insieme ad Arcs/Arci, Legambiente e Fairwatch: “Per noi – conclude Tartaglia – il commercio internazionale deve vedere tutti i soggetti, istituzionali e sociali, sullo stesso piano, e muoversi nell’ottica del pieno rispetto di tutti i diritti, delle prospettive di benessere condiviso e di difesa della buona occupazione in tutti i paesi, salvaguardando i diritti umani e sociali da ogni logica mercantilistica”. Una scelta importante, alla vigilia del lancio della campagna globale in vista dell’Assemblea ministeriale dell’Omc che si terrà a Bali, in Indonesia, dal 3 al 6 dicembre 2013, e che i movimenti vorrebbero trasformare in una nuova Seattle: un’insurrezione pacifica contro la mercificazione dei beni comuni.
* Vicepresidente dell’associazione Fairwatch, insegna Modelli di sviluppo economico alla Pontificia Università Gregoriana
di Monica Di Sisto*